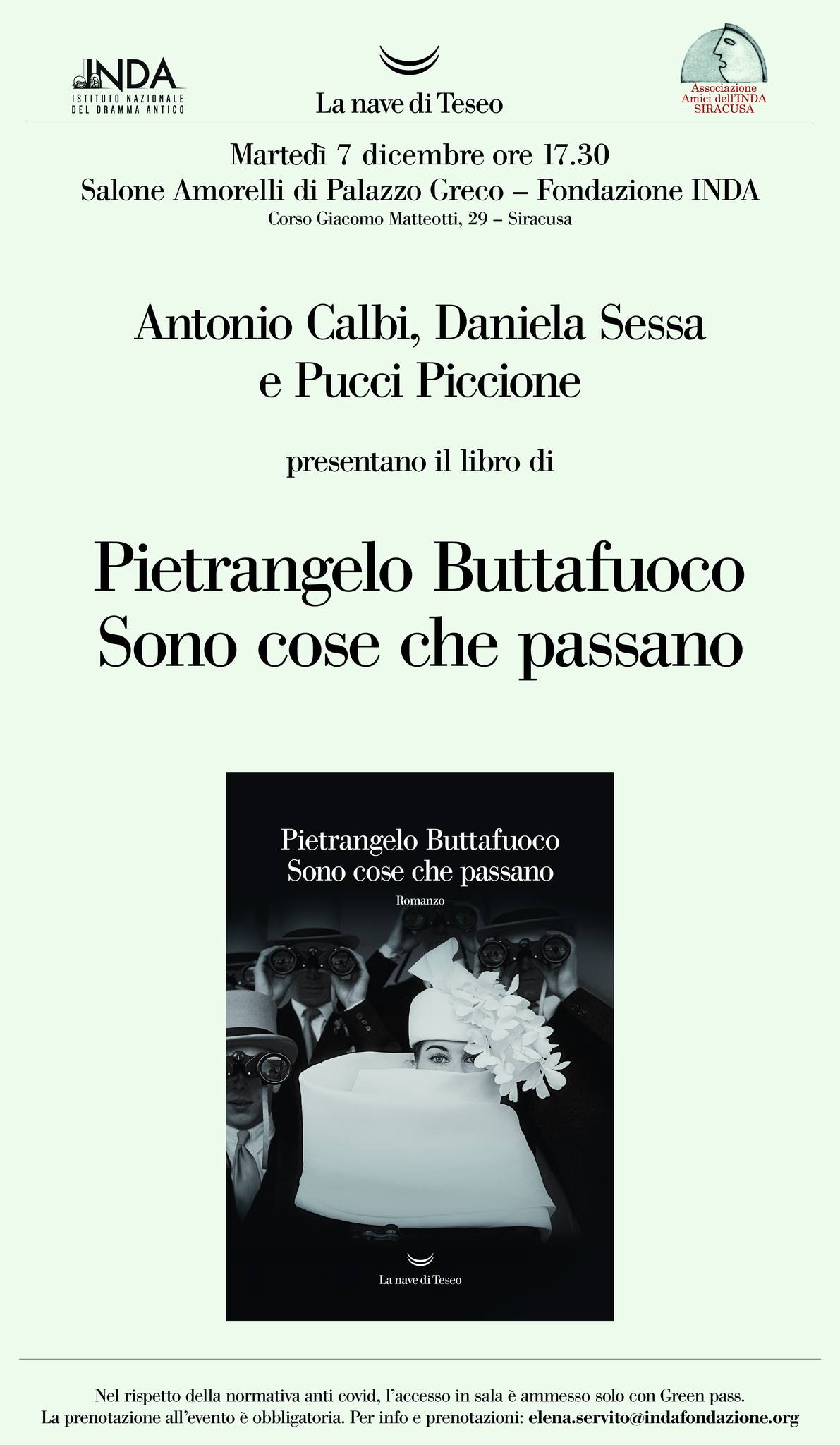LA TRAGEDIA DI SENECA, RISCRITTURA DEL MITO
di Alfio SiracusanoQuello di Medea è uno dei miti più complessi dell’universo greco, peraltro coniugato in più d’una versione, e si intreccia con il ciclo degli Argonauti. Che è ciclo fondante, non meno di quello troiano o di quello edipico, nell’immenso universo di miti cui i greci antichi diedero vita. La sua ratio non si esaurisce infatti nella vicenda che lo conclude, anche se il nome della protagonista e il suo gesto inaudito fanno inevitabilmente pensare a questo epilogo, e affonda invece nell’altra della prima espansione greca ad oriente e del primo contatto con quel mondo di bàrbaroi che poi ne insidieranno la libertà. È un po’ come l’atto di nascita della Ionia, allo stesso modo in cui la peregrinazione odissiaca fu trasfigurazione dell’espansione ad Occidente da cui nasceranno la Megàle Hellàs, la Magna Grecia e la Sicilia con tutto ciò che segue. Che è come dire che in questo mito che ha per protagonisti Giasone e Medea con la storia del loro amore si intrecciano le coordinate dello stesso essere del popolo greco, della sua vocazione ad espandere cultura, delle sue creazioni intellettuali destinate a segnare la storia della civiltà non solo occidentale.
Poi su tutto il resto prevalse – e ciò avvenne a cavallo tra il sesto e quinto secolo, probabilmente a causa dell’espansione persiana che, fagocitate le città della Ionia, metteva in discussione la libertà delle città greche della stessa madrepatria – la versione della maga che, incapricciata di Giasone venuto nella sua Colchide a rubare il vello d’oro su mandato del re tessalo Pelia, lo aiutò a compiere il furto, fuggì con lui dopo avere abbandonato al suo destino il regno del padre Eeta e ucciso il fratello Absirto, provocò la morte del re Pelia ingannando le sue figlie, venne abbandonata dal marito deciso a sposare Creùsa (o Glauce), figlia del re di Corinto, e in un raptus di folle gelosia si vendicò uccidendo la rivale, il di lei padre Creonte e i due figlioletti avuti da Giasone. Per poi involarsi nel cielo su di un carro di fuoco donato dal suo avo Elios e finire in una nuova selva di varianti del mito: in Atene, sposa di Egeo, o di nuovo nella Colchide dove partorì Medo, o sposa di Eracle da lei rinsavito, o compagna di Achille nell’Aldilà.
Naturalmente i poeti non potevano non sentirsi stregati da questo personaggio. Sull’argomento Léon Mallinger scrisse un libro nel lontano 1898, Medée, étude de littérature comparée. La poesia greca è piena di questa figura. Pindaro ne parlò nella Quarta Pitica, i tragici ne fecero tutti la protagonista di almeno una tragedia, anche se dall’immenso naufragio è giunta a noi solo quella di Euripide, Apollonio di Rodi ne ricavò uno splendido personaggio. Lo stesso va detto della poesia latina. Ne trattarono Accio, Pacuvio, Ovidio, Seneca, l’unico di cui ci è rimasta l’opera. Questo tra gli antichi. Tra i moderni ne scrissero Jean de la Péruse, Ludovico Dolce, Pierre Corneille, Bernard de Longepierre, Giovanni Battista Niccolini, Franz Grillparzer, Hippolyte Lucas, per non parlare delle versioni musicali, tra tutte quella di Cherubini. Pasolini ci costruì un film famoso con una splendida Maria Callas nel ruolo della maga, offrendo del mito una truce rilettura che affonda nell’ancestrale dell’umano e della ferinità primigenia del materno femminile quale depositario della vita. Che ci riporta al culto mediterraneo della dea madre ed è la ragione oscura e profonda per cui Medea rivendica quasi come suo diritto quello di uccidere lei i suoi figli. Ancora recentemente è stata ripescata da Christa Wolf per una rilettura di palpitante attualità.
Fu comunque con Euripide che il mito della madre che osa uccidere i figli si consolidò nell’immaginario collettivo. Fu con la sua opera che al deinòs, insieme terribile e divino del personaggio, si aggiunse l’audacissima trasfigurazione della maga, pur restata tale, in donna travolta da passioni di donna, e come tale accolta nell’universale aristotelico della poesia. Capace quindi di trasmettere al pubblico dei cittadini di Atene il senso delle sue ragioni, com’era naturale nelle tragedie greche che sono scontro, appunto, di contrapposte ragioni. Con l’esplicito richiamo al senso storico, reale di ciò che è la gelosia letta al femminile, nel suo crudo collocarsi dentro l’orizzonte del léchos e dell’euné, che significano il letto matrimoniale ma anche le lascivie e i piaceri che in esso si consumano. E proprio questo infatti, nel culmine della disperazione, Giasone rimprovererà alla moglie che sta per uccidere i figli. Incapace di capire, nella sua mediocrità anche culturale, che pure léchos ed euné sono parte nient’affatto secondaria di eros. Cioè della vita reale.
La donna/Medea inventata da Euripide uccide perché incapace di reggere al demone della gelosia, al furto di quei piaceri che sente irrinunciabili, che avverte come suo diritto, e ciò scatena in lei, donna barbara, il ferino, l’aischròs, il tremendo che la rende altra cosa rispetto all’umano equilibrio, che è greco. Ponendola in una sorte di logica del divino, greco anch’esso, ma che ha modalità di comportamenti se non inaccettabili certo difficili da comprendere al senso comune. Che è qualcosa che ha a che vedere con l’arcano terribile della donna/dea come se la figuravano i greci, “terribile nelle sue ire … quanto soave nelle sue grazie” (Diano), feroce coi nemici benevola con gli amici. Euripide esplorò fino in fondo questo abisso duale dell’animo femminile, materializzandolo in due figure esemplari, Medea e Alcesti, la donna che arriva ad uccidere i figli in odio al marito e quella che uccide se stessa per amore di lui. Specchio rovesciato l’una dell’altra, l’una complementare all’altra, perché “nel cuore di Medea c’è anche l’amore che fa sublime Alcesti, così come nel cuore di Alcesti c’è la possibilità di Medea” (id.). Il cui dramma è tutto nel conflitto fra la debolezza senza ragioni di Giasone e le sue ragioni di feroce ancorché inaccettabile determinazione. Che è come dire che nel momento in cui l’umano femminile vedeva riconosciuti i suoi diritti, vedeva anche sancita la sua oscura terribile perversione. Questo in Euripide, nell’Atene del 431 a.C.
Poi Medea si dilatò. Nell’immaginario di Apollonio Rodio, poeta alessandrino del III secolo, si impose l’attenzione al tempo dell’innamoramento, e Medea fu vista fanciulla di un regno straniero misterioso e lontano che subisce l’attrazione fatale del guerriero bello e invincibile, e per questo meritevole di aiuto, che viene da un altro mondo e porta con sé il fascino dell’esotico. Nel terzo libro delle Argonautiche Apollonio raccontò come mai si era fatto prima le fasi di questo incantamento, ricostruendo tutto il percorso di un amore che via via si sospetta, si desidera, si sogna, si immagina, esplode finalmente in innocente irrefrenabile desiderio. Ad esso tutto fu sacrificato: patria, padre, fratello, onore. Dopo Saffo fu il più grande inno all’amore e la più grande esplorazione psicologica di un animo di fanciulla. Anche se l’epilogo tragico, secondario in Apollonio, restava sempre sullo sfondo. Ma fu anche un’altra forma di umanizzazione della figura di Medea, e di essa si ricordò Virgilio quando costruì il personaggio di Didone che si innamora di Enea, come se ne era ricordato Catullo tratteggiando Arianna. Abbandonata anche lei da un uomo che aveva amato e salvato dal Minotauro. Non stupisce che anche Ovidio se ne sia ricordato, a quel che si sa, in un sua tragedia dedicata a Medea. Perduta anch’essa, purtroppo.
Ed eccoci a Seneca, e al suo complesso rapporto con la terribile maga dei Colchi. Ad essa il filosofo venuto da Cordova si accostò soprattutto per il tramite di Euripide, ma non dovettero essergli estranee le altre letture sin qui citate, da quella di Accio all’ultima di Ovidio. E tuttavia il suo approccio non poteva sfuggire, come avvenne per le altre tragedie, alla cifra specifica degli interessi senecani, legati alle problematiche etiche con cui si misurano inevitabilmente gli uomini e le donne di ogni tempo, e che lui esplorò fino in fondo per gli uomini e le donne del suo tempo. Questo vuol dire che, al di là della data di composizione di Medea, peraltro irrisolta, non si può comprendere la tragedia di Seneca se non la si proietta dentro lo sfondo delle Lettere a Lucilio e dei Dialoghi morali, con particolare riguardo al De ira, che più di tutti impegnò Seneca sul tema per eccellenza centrale nella sua speculazione, la natura del potere e i suoi rapporti con esso. Senza dimenticare la centralità che in lui assunse il concetto della clementia, trattato in un dialogo che ci è giunto incompleto. Primo fondamento di un potere virtuoso. La lettura che egli fece di Medea fu dunque una proiezione dei rapporti che il poeta ebbe con Caligola prima ma soprattutto con Claudio e con Nerone e insieme coi letterati del suo tempo, da Lucano a Petronio, che questi Cesari un po’ li blandirono un po’ li osteggiarono, fino a rivoltarsi contro di loro (in realtà contro Nerone) in nome della libertas perduta. Perduta e poi tornata con Nerva, a dire di Tacito. Dopo l’annus horribilis dei tre Cesari. Ma essi pagarono con la vita.
Letta su questo sfondo, la figura di Medea non poteva non poteva più contentarsi della pur audace modernizzazione operata da Euripide. Averla trasformata in “donna” che rivendica un suo ruolo poteva forse bastare nella coltissima Atene del quinto secolo, pervasa delle dispute sofistiche e tesa a decifrare la portata reale dell’essere l’ànthropos, l’uomo, la misura di tutte le cose, come sosteneva Protagora. Era dunque quasi naturale chiedersi perché quest’ànthropos non potesse essere anche la gyné, la donna – che era stato anche il senso dell’opera di Saffo, la quale, solo per fare un esempio, sul personaggio di Elena, che pochi anni dopo la rappresentazione di Medea sarebbe stata difesa da Gorgia nel celebre Elogio, aveva detto cose assai più audaci delle lucide analisi del sofista leontino. Ora però, nella Roma di Seneca, superato quel problema, l’evoluzione dei tempi e le lotte di potere avevano ben altrimenti plasmato le figure delle donne del gran mondo. Cosa che peraltro avveniva già dai tempi della crisi della Repubblica, ma che si era ingigantita con le donne del periodo augusteo per culminare, tra i Cesari Tiberio e Caligola e Claudio e Nerone, nell’immenso scenario di dissolutezza e morte e intrighi di palazzo popolato dei nomi di Giulia, Agrippina, Poppea, Messalina e tante altre. Attrici anche politiche, queste ultime, ben più di quanto lo fossero state le figure femminili che pure erano entrate nei giochi di potere dell’ultima Repubblica.
Ecco perché Medea non poteva più essere solo la donna che in nome dei suoi diritti arriva ad uccidere i figli, e diventa invece, nella lettura di Seneca, proiezione di un tempo pieno di sangue, morte, tirannide ed efferatezze di ogni tipo. Senza nulla ripudiare della modernizzazione di Euripide, essa subisce un’opera di vera e propria temporalizzazione, offrendosi a buona ragione come exemplum di virago di orgoglio smisurato in un tempo che di virago più o meno amate o temute o ammirate certamente abbondava. Ed era anche inevitabile che i toni esasperati dell’intero impianto scenico, con la morte in diretta dei piccoli figli e la terribilità quasi ostentata delle crudeltà perpetrate dalla donna, si alimentassero degli esempi di un tempo feroce che offriva senza risparmio lo spettacolo delle morti in diretta nei ludi gladiatorii in aggiunta a quelle consumate negli intrighi del palazzo. Cose tutte che il Seneca morale delle Lettere e dei Dialoghi aspramente condannava, nella logica della sua pedagogia umanistica della virtus intesa come moderazione, freno della ragione all’irrazionalità dell’istinto. Logos contro àlogon.
In tale contesto la ribellione di Medea diventa ribellione totale, quasi cosmica, che la sublimità dello stile esalta oltre ogni limite. L’oltraggio subito con la minaccia delle nozze imminenti del marito non è solo riflesso dell’offesa insopportabile di una donna, diventa contrapposizione totale, contrasto feroce coll’ordine stesso del mondo così come la storia lo ha costruito. La parole sagge della nutrice, che suggerisce moderazione e paziente rassegnazione non valgono nulla per l’indomita virago. Cielo e terra sono chiamati a testimonianza dell’offesa patita, e affiora una visione di quasi assoluto nichilismo nel giudizio di uomini e istituzioni. Il potere, che si personalizza in Creonte, è pura tirannide. “Se devi giudicare” grida la donna in faccia al re di Corinto venuto a cacciarla via, “ascolta le mie ragioni, se vuoi imporre il tuo potere regale, comanda pure”. E quando si sente rispondere che “giusto o ingiusto che sia, lei dovrà sottostare all’ordine del re”, commenta amara: “I regni ingiusti non potranno mai durare per sempre.” E lei, che fu già regina, lo sa bene, come sa bene quale dovrebbe essere il dovere dei re. Al tiranno che le impone di partire all’istante, e finge di volerla comunque ascoltare in un “processo” il cui esito è scontato, urla sdegnosa: “Fìdati del regno, se poi il caso volubile a suo piacimento ogni bene, per grande che sia, porta via – eppure i re questo potere possiedono, magnifico, immenso, che nessun giorno potrà mai loro sottrarre: aiutare gli infelici, offrire ai supplici ausilio e protezione”.
La sua scelta è tuttavia già compiuta sin dalle prime battute del dramma. Scritta nel mito, contenuta nel nome stesso del personaggio, anche se il suo ètimo rinvia al medéomai, guarire, dare consigli, essere saggia. Ed è scelta cosciente di vendetta non più e non solo personale. Giasone e chi l’ha oltraggiata non hanno solo violato le leggi umane, hanno anche sovvertito l’ordine del cosmo, distrutto la misura antica delle cose. E lei, che c’è piombata in mezzo, diventa ora vittima sacrificale di questa colpa antica, per di più da donna offesa e umiliata. Il coro che segue al colloquio con Creonte canta l’epica della conquista del vello, ma la canta in un’ottica di superbia che distrugge l’ordine voluto dalla natura. Tifi e Giasone e quanti si spinsero ad oriente armati solo della voglia di rapina osarono troppo, peccarono di dismisura, furono empi nella loro audacia. E a lei, alla misera Medea rannicchiata ad ascoltare in un angolo della scena, altro non resta che rammaricarsi di averli aiutati. Non l’avesse mai fatto!, pensa chiusa in se stessa. Non fosse mai accaduto! “Puro, privo d’inganni, fu/ il tempo che conobbero i nostri padri./ Le proprie coste ognuno, quieto, sfiorava/ e, invecchiando nel campo paterno,/ ricco di poco, non conosceva messi altre/ che quelle del suolo natìo./ L’ordine sacro dell’universo, in parti suddiviso,/ la nave téssala precipitò nell’indistinto Chaos/ e a Oceano impose la sferza dei remi;/ il mare, prima lontano,/ parte divenne delle nostre paure.” Ora quel mondo, che non è neanche l’età dell’oro, non c’è più. La superbia venuta dall’occidente lo ha ucciso. E a Medea non resta altro da fare che vendicarlo.
L’oriente, che nell’epica augustea aveva trovato in Virgilio il canto di legittimazione dell’impero universale affidato ai successori di Enea, diventa ora la maledizione della volontà di conquista sorretta dalla sola voglia di rapacità. E Medea, la vergine ingannata dai conquistatori, resa donna dall’amore e ora umiliata come una schiava senza diritti, non esita a rivendicare la sua appartenenza a quel mondo: “Nobile, fortunata, io risplendevo allora del diadema regale: al mio letto nuziale aspiravano i pretendenti cui altri, ora, danno la caccia. Rapace, volubile, improvvisa la sorte mi strappò il regno, me consegnò all’esilio”. La ribellione è anche una riconquista.
Quando compone questa tragedia Seneca non è più da tempo precettore di Nerone. O forse, secondo un’altra ipotesi cronologica, sta finendo di esserlo. Nel cuore dell’imperatore lo ha sostituito. O si accinge a farlo, Tigellino, e il filosofo ha ormai perduto ogni speranza. È esagerato pensare che in quelle parole che Seneca fa pronunciare al coro c’è un preciso richiamo al fallimento della sua missione specifica ma anche a quello, più generale, della politica di conquista di Roma? Alle sue mai concluse campagne orientali, all’inesausta sete di guerre che da sempre accompagnava Roma e inevitabilmente violava “l’ordine sacro dell’universo, in parti suddiviso”? Che significa assegnato a ciascun popolo secondo l’ordine naturale della cose? In una luce di naturale moralità? Se Seneca poté scrivere che l’arroganza nei confronti dei servi era un atto immorale, perché i servi homines sunt, non pare azzardato pensare che anche i popoli sono fatti di uomini e che c’era qualcosa di marcio nella politica di Roma. Era dunque Roma, per Seneca, proiezione di quella nave téssala che precipitò il mondo nell’indistinto Chaos dei tempi cupi che al filosofo toccò di vivere? Un mondo in cui spoliatis arma supersunt, come avrebbe scritto Giovenale qualche decennio dopo?.
La tragedia di Seneca rovescia dunque la visione di Virgilio rispetto alla storia, ma allarga anche l’intuizione di Euripide riguardo alla protagonista, anche se ne accetta la versione del mito. Medea non è più solo donna che reclama i suoi diritti, ma donna/simbolo di una rapina di identità che unifica il mondo secondo le regole del potere tirannico (Creonte/Giasone/Cesari), dentro una logica di sottomissione che scatena l’àlogon della ribellione fuori di misura. L’unica possibile, e quindi necessaria ancorché atroce. Una logica nella quale il disumano della vendetta si fa antidoto al disumano dell’offesa. Spogliata della sua dignità, a Medea rimangono solo le armi della vendetta. È il portato di una cupa visione della storia in tempi di cupe tragedie. In Euripide, cittadino di Atene orgoglioso della superiore civiltà della sua polis, poteva essere detto che “nessuna donna greca avrebbe mai osato tanto”; ora, nella Roma di Seneca, quando tutto era stato osato, chiunque, anche una donna, poteva osare l’inosabile. Anche uccidere i figli sulla scena, in una sorta di rovesciamento del senso catartico che aveva accompagnato la tragedia greca. Nella sua Arte poetica Orazio aveva accolto il suggerimento di Aristotele, diventato regola, che sulla scena tragica non ci potessero essere scene cruente (“Medea non trucidi i figli davanti agli occhi di tutti”, 185). E infatti in Euripide i bambini vengono uccisi fuori dalla scena, e gli spettatori ne sentono solo le urla e poi li vedono sul carro che li porta via. Perché la madre ha scelto di negare al padre anche il diritto di onorarne le salme. In Seneca invece, che racconta un mondo senza luce che non sia quella della moralità contenuta nelle parole dei filosofi, la follia vendicativa di Medea si spinge al punto di far portare sulla scena lo sgozzamento delle povere creature, i cui cadaveri vengono lanciati dall’alto sul padre annichilito. Non si trattò, come troppo spesso si è detto, di un’invenzione ad effetto o di gusto per l’orrido spinto ai massimi livelli, peraltro ricorrente nelle altre tragedie. O almeno solo di questo. Era che il crollo della morale comune, in un mondo nel quale ai sapienti non restava altro che darsi la morte, imponeva che al mondo fosse mostrato tutto l’orrore che lo abitava. Al di là di tutte le cautele. Un po’ come un messaggio che i Lucano, i Petronio, i Seneca, i Cremuzio Cordo, che la tirannide dei Claudii non esitava a spegnere, lasciavano al loro tempo. Tutto questo dovette risultare chiaro nei circoli intellettuali in cui i drammi di Seneca venivano recitati, forse anche “rappresentati” per un pubblico eletto di eletti intenditori.
Sta propriamente qui il senso etico, oltre che pedagogico, del teatro senecano, continuazione della politica con altri mezzi. E dunque anche di questa Medea. E la cosa non dovette essere sfuggita ai contemporanei, se è vero che poco dopo il suo suicidio, che poi Tacito raccontò in pagine memorabili, qualcuno scrisse, imitando il suo stile, l’Octavia, una praetexta in cui si rappresenta la morte “esemplare” del filosofo. Poi tramandata dai codici come opera dello stesso Seneca.
Ma torniamo a Medea, con un’ultima considerazione. Nel suo mondo, ad onta del fatto che lei è anche dea nipote di dei, non ci può essere posto per gli dei, foss’anche ex machina, come nel finale di Euripide (che spiacque ad Aristotele) in cui Medea porta con sé i cadaveri dei figli. Li seppellirà lei perché sono “suoi”, affidandoli ai “suoi” dei. Lontano da Corinto, chissà dove. In Seneca invece, come si è detto, la maga rovescia sul marito i cadaveri dei bambini, volando via sola nel trionfo della sua terribile alterigia. Finalmente paga nel suo gesto disperato. Finalmente se stessa. Lo ha detto poco prima, quando il messaggero racconta la strage compiuta nella reggia: “Ora sono davvero Medea; sì, le sventure che ho patito hanno accresciuto il mio talento. Sono felice, felice di aver strappato la testa a mio fratello, felice di aver fatto a pezzi il suo corpo e di aver sottratto a mio padre l’arcano simbolo sacro, felice di aver armato le mani delle figlie per uccidere quel vecchio”. E dunque paradossalmente “felice” anche dopo avere ucciso i figli. La seguono le ultime parole di Giasone, insieme disperate e rassegnate, a dire che dove passa lei, non ci sono dei: “Sì, va’ pure per gli spazi profondi del cielo; va’ a dimostrare che non ci sono dèi dove tu passi” (trad. di Giusto Picone. Ma Mario Scandola traduce più brutalmente: “Va’, testimonia, dovunque passerai, che gli dei non esistono”). Che era più probabilmente il pensiero di Seneca.
Né poteva essere altrimenti. In un mondo che assiste alla disfatta del logos non c’è davvero spazio per gli dei, inutile orpello quando non sciocca credenza degli uomini incapaci di farsi della virtù il loro dio. Indifferenti comunque alle sofferenze umane, gelidi e lontani come in Lucrezio, così caro a Seneca, o addirittura inesistenti, pura proiezione delle debolezze umane, come aveva già sentenziato il messinese Evemero, ed era nel disincantato stoicismo del filosofo poeta. E in questo disincanto l’uomo è solo, con la sua virtù o la sua pochezza. Quel disperato nullos esse qua veharis deos, non a caso posto a sigillo della tragedia, mentre colloca il gesto di Medea in un mondo senza dei, diventa disperata denuncia di un “vero” che distrugge ogni illusione e si fa stigma definitivo di un tempo non più uguale a quello di prima. E questo, singolarmente, mentre in quegli stessi anni Paolo di Tarso si ingegnava a forgiare, sulla fine degli “dei” antichi e folgorato da una “rivelazione” fortemente creduta, una cultura fondata su un altro “dio”, unico e pensato nella forma di un’altra eticità. Un’eticità trascendente, fondata su un “amore” non più eros ma agapé, che insieme negava ed inverava l’eticità immanente del filosofo di Cordova, basata tutta sulla virtus. Ma virtus umana, fondata sulle parole e sugli atti degli uomini.
La verità è che con Paolo di Tarso stava nascendo un altro mondo, che Seneca non poteva neanche immaginare. Quello di Seneca, che sarebbe durato ancora a lungo, era ancora lì, fino a quando anche su di esso non avrebbe operato la tagliola del tempo. Mondo senza dei o con solo il loro esteriore apparato, ora tollerante ora sporcato da feroci intolleranze. Ma rimane il fatto che quando Medea uccide i figli, e lo fa davanti a tutti, sulla scena del mondo, nel pensiero di Seneca essa uccide anche l’idea stessa di Dio. Neanche Euripide, che pure si era chiesto più di una volta se gli dei ci sono, era giunto a tanto.LA TRAGEDIA DI SENECA, RISCRITTURA DEL MITO
di Alfio SiracusanoQuello di Medea è uno dei miti più complessi dell’universo greco, peraltro coniugato in più d’una versione, e si intreccia con il ciclo degli Argonauti. Che è ciclo fondante, non meno di quello troiano o di quello edipico, nell’immenso universo di miti cui i greci antichi diedero vita. La sua ratio non si esaurisce infatti nella vicenda che lo conclude, anche se il nome della protagonista e il suo gesto inaudito fanno inevitabilmente pensare a questo epilogo, e affonda invece nell’altra della prima espansione greca ad oriente e del primo contatto con quel mondo di bàrbaroi che poi ne insidieranno la libertà. È un po’ come l’atto di nascita della Ionia, allo stesso modo in cui la peregrinazione odissiaca fu trasfigurazione dell’espansione ad Occidente da cui nasceranno la Megàle Hellàs, la Magna Grecia e la Sicilia con tutto ciò che segue. Che è come dire che in questo mito che ha per protagonisti Giasone e Medea con la storia del loro amore si intrecciano le coordinate dello stesso essere del popolo greco, della sua vocazione ad espandere cultura, delle sue creazioni intellettuali destinate a segnare la storia della civiltà non solo occidentale.
Poi su tutto il resto prevalse – e ciò avvenne a cavallo tra il sesto e quinto secolo, probabilmente a causa dell’espansione persiana che, fagocitate le città della Ionia, metteva in discussione la libertà delle città greche della stessa madrepatria – la versione della maga che, incapricciata di Giasone venuto nella sua Colchide a rubare il vello d’oro su mandato del re tessalo Pelia, lo aiutò a compiere il furto, fuggì con lui dopo avere abbandonato al suo destino il regno del padre Eeta e ucciso il fratello Absirto, provocò la morte del re Pelia ingannando le sue figlie, venne abbandonata dal marito deciso a sposare Creùsa (o Glauce), figlia del re di Corinto, e in un raptus di folle gelosia si vendicò uccidendo la rivale, il di lei padre Creonte e i due figlioletti avuti da Giasone. Per poi involarsi nel cielo su di un carro di fuoco donato dal suo avo Elios e finire in una nuova selva di varianti del mito: in Atene, sposa di Egeo, o di nuovo nella Colchide dove partorì Medo, o sposa di Eracle da lei rinsavito, o compagna di Achille nell’Aldilà.
Naturalmente i poeti non potevano non sentirsi stregati da questo personaggio. Sull’argomento Léon Mallinger scrisse un libro nel lontano 1898, Medée, étude de littérature comparée. La poesia greca è piena di questa figura. Pindaro ne parlò nella Quarta Pitica, i tragici ne fecero tutti la protagonista di almeno una tragedia, anche se dall’immenso naufragio è giunta a noi solo quella di Euripide, Apollonio di Rodi ne ricavò uno splendido personaggio. Lo stesso va detto della poesia latina. Ne trattarono Accio, Pacuvio, Ovidio, Seneca, l’unico di cui ci è rimasta l’opera. Questo tra gli antichi. Tra i moderni ne scrissero Jean de la Péruse, Ludovico Dolce, Pierre Corneille, Bernard de Longepierre, Giovanni Battista Niccolini, Franz Grillparzer, Hippolyte Lucas, per non parlare delle versioni musicali, tra tutte quella di Cherubini. Pasolini ci costruì un film famoso con una splendida Maria Callas nel ruolo della maga, offrendo del mito una truce rilettura che affonda nell’ancestrale dell’umano e della ferinità primigenia del materno femminile quale depositario della vita. Che ci riporta al culto mediterraneo della dea madre ed è la ragione oscura e profonda per cui Medea rivendica quasi come suo diritto quello di uccidere lei i suoi figli. Ancora recentemente è stata ripescata da Christa Wolf per una rilettura di palpitante attualità.
Fu comunque con Euripide che il mito della madre che osa uccidere i figli si consolidò nell’immaginario collettivo. Fu con la sua opera che al deinòs, insieme terribile e divino del personaggio, si aggiunse l’audacissima trasfigurazione della maga, pur restata tale, in donna travolta da passioni di donna, e come tale accolta nell’universale aristotelico della poesia. Capace quindi di trasmettere al pubblico dei cittadini di Atene il senso delle sue ragioni, com’era naturale nelle tragedie greche che sono scontro, appunto, di contrapposte ragioni. Con l’esplicito richiamo al senso storico, reale di ciò che è la gelosia letta al femminile, nel suo crudo collocarsi dentro l’orizzonte del léchos e dell’euné, che significano il letto matrimoniale ma anche le lascivie e i piaceri che in esso si consumano. E proprio questo infatti, nel culmine della disperazione, Giasone rimprovererà alla moglie che sta per uccidere i figli. Incapace di capire, nella sua mediocrità anche culturale, che pure léchos ed euné sono parte nient’affatto secondaria di eros. Cioè della vita reale.
La donna/Medea inventata da Euripide uccide perché incapace di reggere al demone della gelosia, al furto di quei piaceri che sente irrinunciabili, che avverte come suo diritto, e ciò scatena in lei, donna barbara, il ferino, l’aischròs, il tremendo che la rende altra cosa rispetto all’umano equilibrio, che è greco. Ponendola in una sorte di logica del divino, greco anch’esso, ma che ha modalità di comportamenti se non inaccettabili certo difficili da comprendere al senso comune. Che è qualcosa che ha a che vedere con l’arcano terribile della donna/dea come se la figuravano i greci, “terribile nelle sue ire … quanto soave nelle sue grazie” (Diano), feroce coi nemici benevola con gli amici. Euripide esplorò fino in fondo questo abisso duale dell’animo femminile, materializzandolo in due figure esemplari, Medea e Alcesti, la donna che arriva ad uccidere i figli in odio al marito e quella che uccide se stessa per amore di lui. Specchio rovesciato l’una dell’altra, l’una complementare all’altra, perché “nel cuore di Medea c’è anche l’amore che fa sublime Alcesti, così come nel cuore di Alcesti c’è la possibilità di Medea” (id.). Il cui dramma è tutto nel conflitto fra la debolezza senza ragioni di Giasone e le sue ragioni di feroce ancorché inaccettabile determinazione. Che è come dire che nel momento in cui l’umano femminile vedeva riconosciuti i suoi diritti, vedeva anche sancita la sua oscura terribile perversione. Questo in Euripide, nell’Atene del 431 a.C.
Poi Medea si dilatò. Nell’immaginario di Apollonio Rodio, poeta alessandrino del III secolo, si impose l’attenzione al tempo dell’innamoramento, e Medea fu vista fanciulla di un regno straniero misterioso e lontano che subisce l’attrazione fatale del guerriero bello e invincibile, e per questo meritevole di aiuto, che viene da un altro mondo e porta con sé il fascino dell’esotico. Nel terzo libro delle Argonautiche Apollonio raccontò come mai si era fatto prima le fasi di questo incantamento, ricostruendo tutto il percorso di un amore che via via si sospetta, si desidera, si sogna, si immagina, esplode finalmente in innocente irrefrenabile desiderio. Ad esso tutto fu sacrificato: patria, padre, fratello, onore. Dopo Saffo fu il più grande inno all’amore e la più grande esplorazione psicologica di un animo di fanciulla. Anche se l’epilogo tragico, secondario in Apollonio, restava sempre sullo sfondo. Ma fu anche un’altra forma di umanizzazione della figura di Medea, e di essa si ricordò Virgilio quando costruì il personaggio di Didone che si innamora di Enea, come se ne era ricordato Catullo tratteggiando Arianna. Abbandonata anche lei da un uomo che aveva amato e salvato dal Minotauro. Non stupisce che anche Ovidio se ne sia ricordato, a quel che si sa, in un sua tragedia dedicata a Medea. Perduta anch’essa, purtroppo.
Ed eccoci a Seneca, e al suo complesso rapporto con la terribile maga dei Colchi. Ad essa il filosofo venuto da Cordova si accostò soprattutto per il tramite di Euripide, ma non dovettero essergli estranee le altre letture sin qui citate, da quella di Accio all’ultima di Ovidio. E tuttavia il suo approccio non poteva sfuggire, come avvenne per le altre tragedie, alla cifra specifica degli interessi senecani, legati alle problematiche etiche con cui si misurano inevitabilmente gli uomini e le donne di ogni tempo, e che lui esplorò fino in fondo per gli uomini e le donne del suo tempo. Questo vuol dire che, al di là della data di composizione di Medea, peraltro irrisolta, non si può comprendere la tragedia di Seneca se non la si proietta dentro lo sfondo delle Lettere a Lucilio e dei Dialoghi morali, con particolare riguardo al De ira, che più di tutti impegnò Seneca sul tema per eccellenza centrale nella sua speculazione, la natura del potere e i suoi rapporti con esso. Senza dimenticare la centralità che in lui assunse il concetto della clementia, trattato in un dialogo che ci è giunto incompleto. Primo fondamento di un potere virtuoso. La lettura che egli fece di Medea fu dunque una proiezione dei rapporti che il poeta ebbe con Caligola prima ma soprattutto con Claudio e con Nerone e insieme coi letterati del suo tempo, da Lucano a Petronio, che questi Cesari un po’ li blandirono un po’ li osteggiarono, fino a rivoltarsi contro di loro (in realtà contro Nerone) in nome della libertas perduta. Perduta e poi tornata con Nerva, a dire di Tacito. Dopo l’annus horribilis dei tre Cesari. Ma essi pagarono con la vita.
Letta su questo sfondo, la figura di Medea non poteva non poteva più contentarsi della pur audace modernizzazione operata da Euripide. Averla trasformata in “donna” che rivendica un suo ruolo poteva forse bastare nella coltissima Atene del quinto secolo, pervasa delle dispute sofistiche e tesa a decifrare la portata reale dell’essere l’ànthropos, l’uomo, la misura di tutte le cose, come sosteneva Protagora. Era dunque quasi naturale chiedersi perché quest’ànthropos non potesse essere anche la gyné, la donna – che era stato anche il senso dell’opera di Saffo, la quale, solo per fare un esempio, sul personaggio di Elena, che pochi anni dopo la rappresentazione di Medea sarebbe stata difesa da Gorgia nel celebre Elogio, aveva detto cose assai più audaci delle lucide analisi del sofista leontino. Ora però, nella Roma di Seneca, superato quel problema, l’evoluzione dei tempi e le lotte di potere avevano ben altrimenti plasmato le figure delle donne del gran mondo. Cosa che peraltro avveniva già dai tempi della crisi della Repubblica, ma che si era ingigantita con le donne del periodo augusteo per culminare, tra i Cesari Tiberio e Caligola e Claudio e Nerone, nell’immenso scenario di dissolutezza e morte e intrighi di palazzo popolato dei nomi di Giulia, Agrippina, Poppea, Messalina e tante altre. Attrici anche politiche, queste ultime, ben più di quanto lo fossero state le figure femminili che pure erano entrate nei giochi di potere dell’ultima Repubblica.
Ecco perché Medea non poteva più essere solo la donna che in nome dei suoi diritti arriva ad uccidere i figli, e diventa invece, nella lettura di Seneca, proiezione di un tempo pieno di sangue, morte, tirannide ed efferatezze di ogni tipo. Senza nulla ripudiare della modernizzazione di Euripide, essa subisce un’opera di vera e propria temporalizzazione, offrendosi a buona ragione come exemplum di virago di orgoglio smisurato in un tempo che di virago più o meno amate o temute o ammirate certamente abbondava. Ed era anche inevitabile che i toni esasperati dell’intero impianto scenico, con la morte in diretta dei piccoli figli e la terribilità quasi ostentata delle crudeltà perpetrate dalla donna, si alimentassero degli esempi di un tempo feroce che offriva senza risparmio lo spettacolo delle morti in diretta nei ludi gladiatorii in aggiunta a quelle consumate negli intrighi del palazzo. Cose tutte che il Seneca morale delle Lettere e dei Dialoghi aspramente condannava, nella logica della sua pedagogia umanistica della virtus intesa come moderazione, freno della ragione all’irrazionalità dell’istinto. Logos contro àlogon.
In tale contesto la ribellione di Medea diventa ribellione totale, quasi cosmica, che la sublimità dello stile esalta oltre ogni limite. L’oltraggio subito con la minaccia delle nozze imminenti del marito non è solo riflesso dell’offesa insopportabile di una donna, diventa contrapposizione totale, contrasto feroce coll’ordine stesso del mondo così come la storia lo ha costruito. La parole sagge della nutrice, che suggerisce moderazione e paziente rassegnazione non valgono nulla per l’indomita virago. Cielo e terra sono chiamati a testimonianza dell’offesa patita, e affiora una visione di quasi assoluto nichilismo nel giudizio di uomini e istituzioni. Il potere, che si personalizza in Creonte, è pura tirannide. “Se devi giudicare” grida la donna in faccia al re di Corinto venuto a cacciarla via, “ascolta le mie ragioni, se vuoi imporre il tuo potere regale, comanda pure”. E quando si sente rispondere che “giusto o ingiusto che sia, lei dovrà sottostare all’ordine del re”, commenta amara: “I regni ingiusti non potranno mai durare per sempre.” E lei, che fu già regina, lo sa bene, come sa bene quale dovrebbe essere il dovere dei re. Al tiranno che le impone di partire all’istante, e finge di volerla comunque ascoltare in un “processo” il cui esito è scontato, urla sdegnosa: “Fìdati del regno, se poi il caso volubile a suo piacimento ogni bene, per grande che sia, porta via – eppure i re questo potere possiedono, magnifico, immenso, che nessun giorno potrà mai loro sottrarre: aiutare gli infelici, offrire ai supplici ausilio e protezione”.
La sua scelta è tuttavia già compiuta sin dalle prime battute del dramma. Scritta nel mito, contenuta nel nome stesso del personaggio, anche se il suo ètimo rinvia al medéomai, guarire, dare consigli, essere saggia. Ed è scelta cosciente di vendetta non più e non solo personale. Giasone e chi l’ha oltraggiata non hanno solo violato le leggi umane, hanno anche sovvertito l’ordine del cosmo, distrutto la misura antica delle cose. E lei, che c’è piombata in mezzo, diventa ora vittima sacrificale di questa colpa antica, per di più da donna offesa e umiliata. Il coro che segue al colloquio con Creonte canta l’epica della conquista del vello, ma la canta in un’ottica di superbia che distrugge l’ordine voluto dalla natura. Tifi e Giasone e quanti si spinsero ad oriente armati solo della voglia di rapina osarono troppo, peccarono di dismisura, furono empi nella loro audacia. E a lei, alla misera Medea rannicchiata ad ascoltare in un angolo della scena, altro non resta che rammaricarsi di averli aiutati. Non l’avesse mai fatto!, pensa chiusa in se stessa. Non fosse mai accaduto! “Puro, privo d’inganni, fu/ il tempo che conobbero i nostri padri./ Le proprie coste ognuno, quieto, sfiorava/ e, invecchiando nel campo paterno,/ ricco di poco, non conosceva messi altre/ che quelle del suolo natìo./ L’ordine sacro dell’universo, in parti suddiviso,/ la nave téssala precipitò nell’indistinto Chaos/ e a Oceano impose la sferza dei remi;/ il mare, prima lontano,/ parte divenne delle nostre paure.” Ora quel mondo, che non è neanche l’età dell’oro, non c’è più. La superbia venuta dall’occidente lo ha ucciso. E a Medea non resta altro da fare che vendicarlo.
L’oriente, che nell’epica augustea aveva trovato in Virgilio il canto di legittimazione dell’impero universale affidato ai successori di Enea, diventa ora la maledizione della volontà di conquista sorretta dalla sola voglia di rapacità. E Medea, la vergine ingannata dai conquistatori, resa donna dall’amore e ora umiliata come una schiava senza diritti, non esita a rivendicare la sua appartenenza a quel mondo: “Nobile, fortunata, io risplendevo allora del diadema regale: al mio letto nuziale aspiravano i pretendenti cui altri, ora, danno la caccia. Rapace, volubile, improvvisa la sorte mi strappò il regno, me consegnò all’esilio”. La ribellione è anche una riconquista.
Quando compone questa tragedia Seneca non è più da tempo precettore di Nerone. O forse, secondo un’altra ipotesi cronologica, sta finendo di esserlo. Nel cuore dell’imperatore lo ha sostituito. O si accinge a farlo, Tigellino, e il filosofo ha ormai perduto ogni speranza. È esagerato pensare che in quelle parole che Seneca fa pronunciare al coro c’è un preciso richiamo al fallimento della sua missione specifica ma anche a quello, più generale, della politica di conquista di Roma? Alle sue mai concluse campagne orientali, all’inesausta sete di guerre che da sempre accompagnava Roma e inevitabilmente violava “l’ordine sacro dell’universo, in parti suddiviso”? Che significa assegnato a ciascun popolo secondo l’ordine naturale della cose? In una luce di naturale moralità? Se Seneca poté scrivere che l’arroganza nei confronti dei servi era un atto immorale, perché i servi homines sunt, non pare azzardato pensare che anche i popoli sono fatti di uomini e che c’era qualcosa di marcio nella politica di Roma. Era dunque Roma, per Seneca, proiezione di quella nave téssala che precipitò il mondo nell’indistinto Chaos dei tempi cupi che al filosofo toccò di vivere? Un mondo in cui spoliatis arma supersunt, come avrebbe scritto Giovenale qualche decennio dopo?.
La tragedia di Seneca rovescia dunque la visione di Virgilio rispetto alla storia, ma allarga anche l’intuizione di Euripide riguardo alla protagonista, anche se ne accetta la versione del mito. Medea non è più solo donna che reclama i suoi diritti, ma donna/simbolo di una rapina di identità che unifica il mondo secondo le regole del potere tirannico (Creonte/Giasone/Cesari), dentro una logica di sottomissione che scatena l’àlogon della ribellione fuori di misura. L’unica possibile, e quindi necessaria ancorché atroce. Una logica nella quale il disumano della vendetta si fa antidoto al disumano dell’offesa. Spogliata della sua dignità, a Medea rimangono solo le armi della vendetta. È il portato di una cupa visione della storia in tempi di cupe tragedie. In Euripide, cittadino di Atene orgoglioso della superiore civiltà della sua polis, poteva essere detto che “nessuna donna greca avrebbe mai osato tanto”; ora, nella Roma di Seneca, quando tutto era stato osato, chiunque, anche una donna, poteva osare l’inosabile. Anche uccidere i figli sulla scena, in una sorta di rovesciamento del senso catartico che aveva accompagnato la tragedia greca. Nella sua Arte poetica Orazio aveva accolto il suggerimento di Aristotele, diventato regola, che sulla scena tragica non ci potessero essere scene cruente (“Medea non trucidi i figli davanti agli occhi di tutti”, 185). E infatti in Euripide i bambini vengono uccisi fuori dalla scena, e gli spettatori ne sentono solo le urla e poi li vedono sul carro che li porta via. Perché la madre ha scelto di negare al padre anche il diritto di onorarne le salme. In Seneca invece, che racconta un mondo senza luce che non sia quella della moralità contenuta nelle parole dei filosofi, la follia vendicativa di Medea si spinge al punto di far portare sulla scena lo sgozzamento delle povere creature, i cui cadaveri vengono lanciati dall’alto sul padre annichilito. Non si trattò, come troppo spesso si è detto, di un’invenzione ad effetto o di gusto per l’orrido spinto ai massimi livelli, peraltro ricorrente nelle altre tragedie. O almeno solo di questo. Era che il crollo della morale comune, in un mondo nel quale ai sapienti non restava altro che darsi la morte, imponeva che al mondo fosse mostrato tutto l’orrore che lo abitava. Al di là di tutte le cautele. Un po’ come un messaggio che i Lucano, i Petronio, i Seneca, i Cremuzio Cordo, che la tirannide dei Claudii non esitava a spegnere, lasciavano al loro tempo. Tutto questo dovette risultare chiaro nei circoli intellettuali in cui i drammi di Seneca venivano recitati, forse anche “rappresentati” per un pubblico eletto di eletti intenditori.
Sta propriamente qui il senso etico, oltre che pedagogico, del teatro senecano, continuazione della politica con altri mezzi. E dunque anche di questa Medea. E la cosa non dovette essere sfuggita ai contemporanei, se è vero che poco dopo il suo suicidio, che poi Tacito raccontò in pagine memorabili, qualcuno scrisse, imitando il suo stile, l’Octavia, una praetexta in cui si rappresenta la morte “esemplare” del filosofo. Poi tramandata dai codici come opera dello stesso Seneca.
Ma torniamo a Medea, con un’ultima considerazione. Nel suo mondo, ad onta del fatto che lei è anche dea nipote di dei, non ci può essere posto per gli dei, foss’anche ex machina, come nel finale di Euripide (che spiacque ad Aristotele) in cui Medea porta con sé i cadaveri dei figli. Li seppellirà lei perché sono “suoi”, affidandoli ai “suoi” dei. Lontano da Corinto, chissà dove. In Seneca invece, come si è detto, la maga rovescia sul marito i cadaveri dei bambini, volando via sola nel trionfo della sua terribile alterigia. Finalmente paga nel suo gesto disperato. Finalmente se stessa. Lo ha detto poco prima, quando il messaggero racconta la strage compiuta nella reggia: “Ora sono davvero Medea; sì, le sventure che ho patito hanno accresciuto il mio talento. Sono felice, felice di aver strappato la testa a mio fratello, felice di aver fatto a pezzi il suo corpo e di aver sottratto a mio padre l’arcano simbolo sacro, felice di aver armato le mani delle figlie per uccidere quel vecchio”. E dunque paradossalmente “felice” anche dopo avere ucciso i figli. La seguono le ultime parole di Giasone, insieme disperate e rassegnate, a dire che dove passa lei, non ci sono dei: “Sì, va’ pure per gli spazi profondi del cielo; va’ a dimostrare che non ci sono dèi dove tu passi” (trad. di Giusto Picone. Ma Mario Scandola traduce più brutalmente: “Va’, testimonia, dovunque passerai, che gli dei non esistono”). Che era più probabilmente il pensiero di Seneca.
Né poteva essere altrimenti. In un mondo che assiste alla disfatta del logos non c’è davvero spazio per gli dei, inutile orpello quando non sciocca credenza degli uomini incapaci di farsi della virtù il loro dio. Indifferenti comunque alle sofferenze umane, gelidi e lontani come in Lucrezio, così caro a Seneca, o addirittura inesistenti, pura proiezione delle debolezze umane, come aveva già sentenziato il messinese Evemero, ed era nel disincantato stoicismo del filosofo poeta. E in questo disincanto l’uomo è solo, con la sua virtù o la sua pochezza. Quel disperato nullos esse qua veharis deos, non a caso posto a sigillo della tragedia, mentre colloca il gesto di Medea in un mondo senza dei, diventa disperata denuncia di un “vero” che distrugge ogni illusione e si fa stigma definitivo di un tempo non più uguale a quello di prima. E questo, singolarmente, mentre in quegli stessi anni Paolo di Tarso si ingegnava a forgiare, sulla fine degli “dei” antichi e folgorato da una “rivelazione” fortemente creduta, una cultura fondata su un altro “dio”, unico e pensato nella forma di un’altra eticità. Un’eticità trascendente, fondata su un “amore” non più eros ma agapé, che insieme negava ed inverava l’eticità immanente del filosofo di Cordova, basata tutta sulla virtus. Ma virtus umana, fondata sulle parole e sugli atti degli uomini.
La verità è che con Paolo di Tarso stava nascendo un altro mondo, che Seneca non poteva neanche immaginare. Quello di Seneca, che sarebbe durato ancora a lungo, era ancora lì, fino a quando anche su di esso non avrebbe operato la tagliola del tempo. Mondo senza dei o con solo il loro esteriore apparato, ora tollerante ora sporcato da feroci intolleranze. Ma rimane il fatto che quando Medea uccide i figli, e lo fa davanti a tutti, sulla scena del mondo, nel pensiero di Seneca essa uccide anche l’idea stessa di Dio. Neanche Euripide, che pure si era chiesto più di una volta se gli dei ci sono, era giunto a tanto.