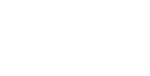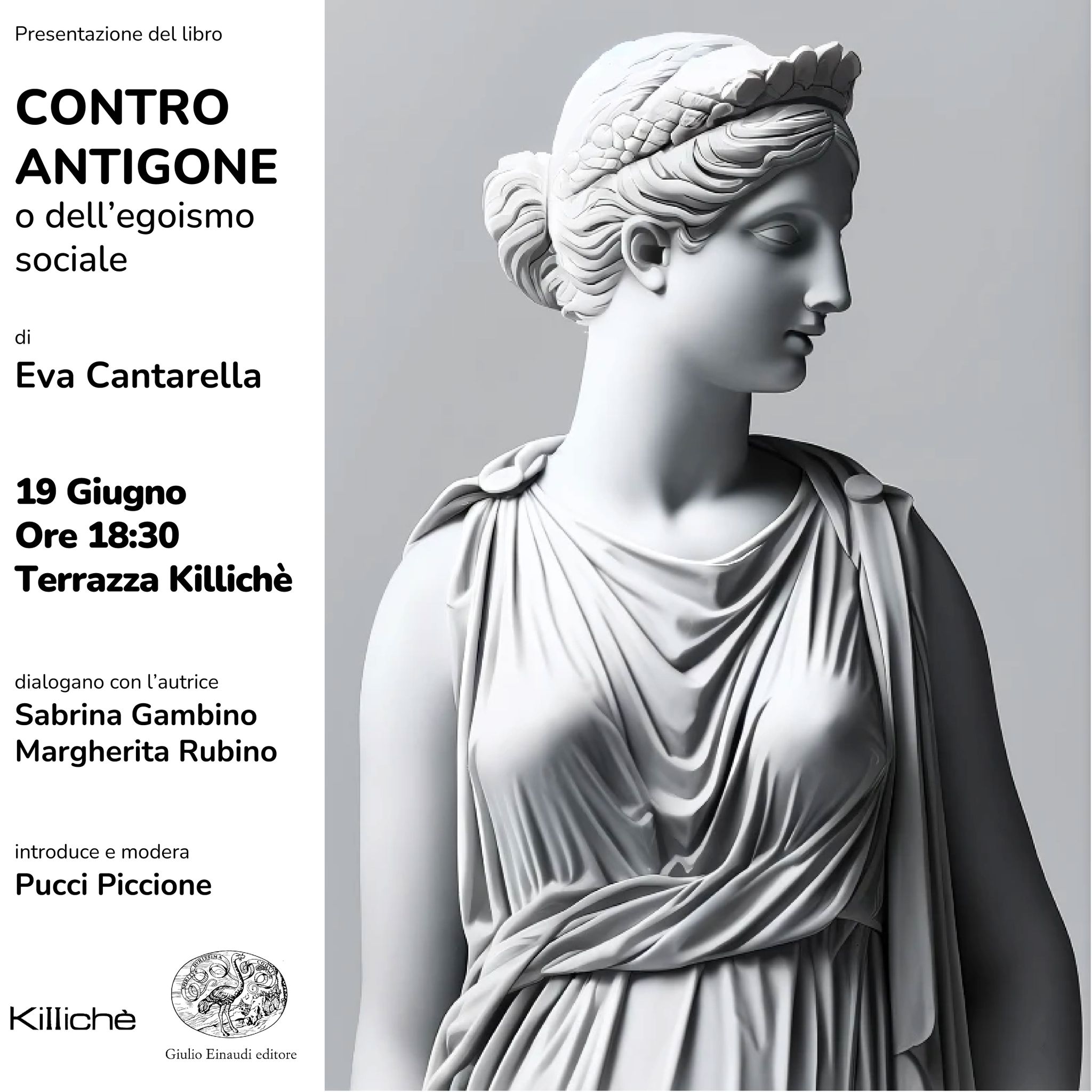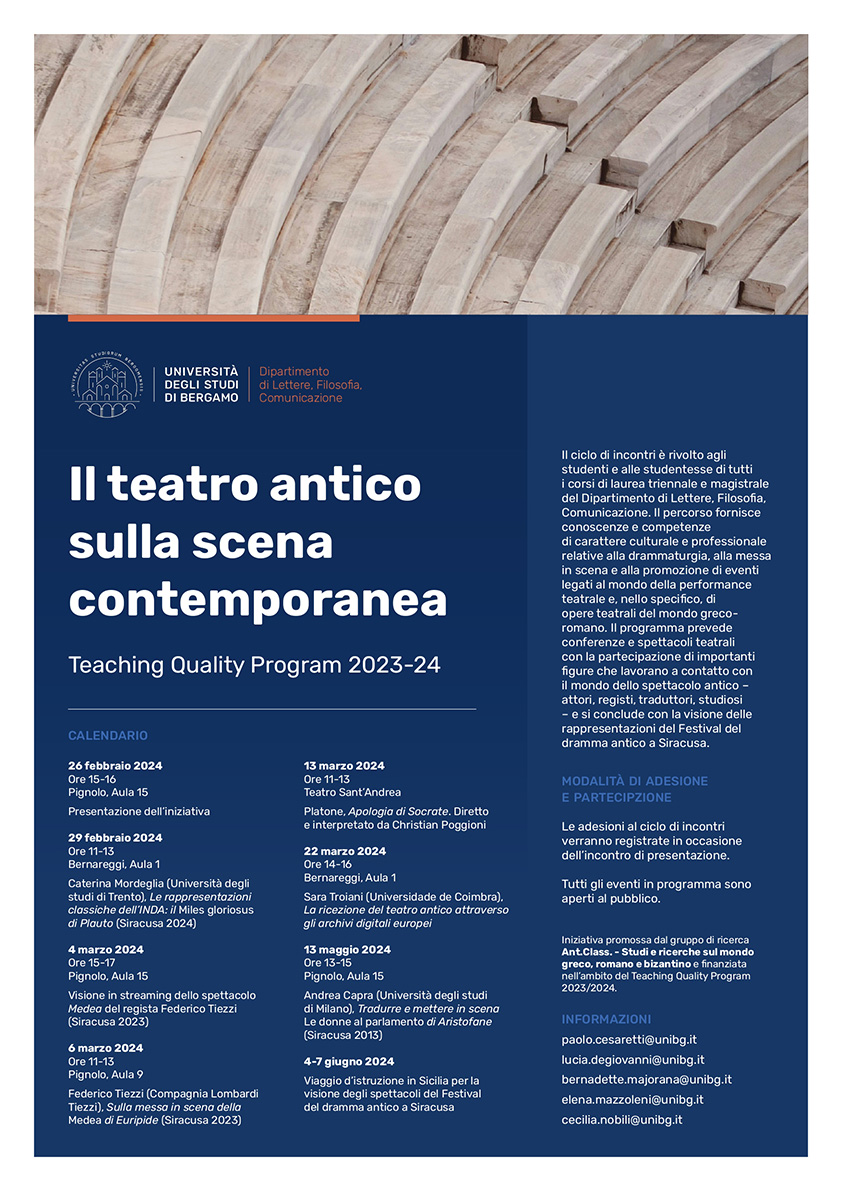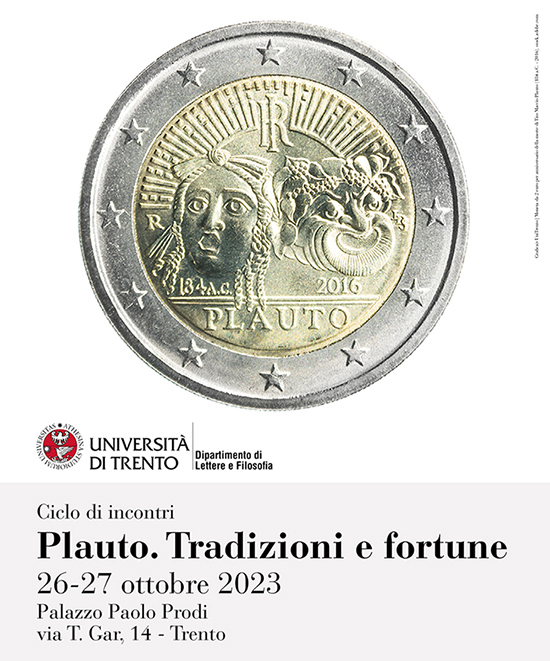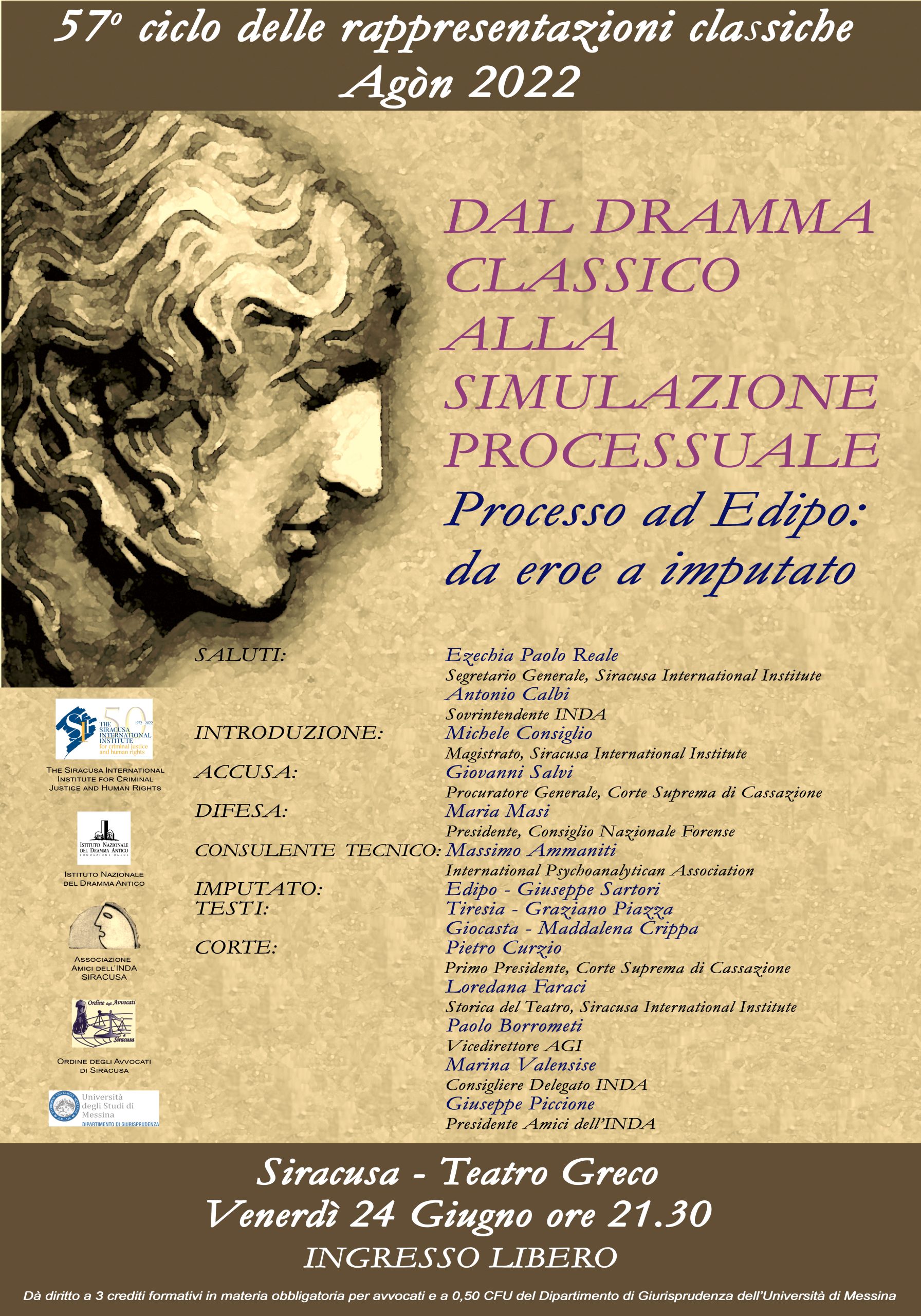Il titolo “Mediterraneo polifonico” può risultare criptico o, per lo meno, stravagante. In effetti non era pensato come titolo e deriva da un’espressione che ho usato scambiando alcuni pareri con l’amico e collega Antonio Brusa. Cercavo di mettere in risalto come il Mediterraneo, il mare interno degli antichi, che ora viene presentato come teatro del grande scontro di civiltà , fosse descritto dai Greci, principalmente, come via di contatti, incroci, scambi di merci, di lingue, di pareri e di voci, di donne. Come, in altri termini, i Greci si rappresentassero il Mediterraneo (in senso stretto di Egeo e in quello lato, compreso tra le colonne d’Ercole e il Ponto) solcato da rotte antichissime, via di comunicazione e non di divisione tra popoli alla lontana imparentati tra loro, scenario di forme di reciprocità di lunga durata, di matrimoni e di ospitalità che, occasionalmente, erano degenerate e potevano degenerare in ostilità. Polifonico dunque per evocare, in tempi di revisionismo genealogico (di puristica selezione delle radici che procede di conserva con la progressiva erosione dello spazio dedicato storia antica nelle scuole: conoscere meno per mistificare di più e meglio?), un’antica concertazione di suoni e, per estensione, di culture, in diretta opposizione al significato etimologico di barbaros . Il termine, chiaramente onomatopeico con decisa pertinenza linguistica, in greco antico è attestato soprattutto come qualificativo dei nomi phoné , suono o voce, e glossa , lingua. Appare dunque coniato per cogliere o, meglio, per riprodurre gli strani suoni e le cacofonie che le lingue non greche avevano per l’orecchio greco tutte le volte che lo incontravano. E si incontravano spesso Greci e non Greci, proprio sulle rotte del Mediterraneo, specie orientale, più facilmente percorribili degli accidentati territori peninsulari e insulari protesi nell’Egeo…
Il titolo “Mediterraneo polifonico” può risultare criptico o, per lo meno, stravagante. In effetti non era pensato come titolo e deriva da un’espressione che ho usato scambiando alcuni pareri con l’amico e collega Antonio Brusa. Cercavo di mettere in risalto come il Mediterraneo, il mare interno degli antichi, che ora viene presentato come teatro del grande scontro di civiltà , fosse descritto dai Greci, principalmente, come via di contatti, incroci, scambi di merci, di lingue, di pareri e di voci, di donne. Come, in altri termini, i Greci si rappresentassero il Mediterraneo (in senso stretto di Egeo e in quello lato, compreso tra le colonne d’Ercole e il Ponto) solcato da rotte antichissime, via di comunicazione e non di divisione tra popoli alla lontana imparentati tra loro, scenario di forme di reciprocità di lunga durata, di matrimoni e di ospitalità che, occasionalmente, erano degenerate e potevano degenerare in ostilità. Polifonico dunque per evocare, in tempi di revisionismo genealogico (di puristica selezione delle radici che procede di conserva con la progressiva erosione dello spazio dedicato storia antica nelle scuole: conoscere meno per mistificare di più e meglio?), un’antica concertazione di suoni e, per estensione, di culture, in diretta opposizione al significato etimologico di barbaros . Il termine, chiaramente onomatopeico con decisa pertinenza linguistica, in greco antico è attestato soprattutto come qualificativo dei nomi phoné , suono o voce, e glossa , lingua. Appare dunque coniato per cogliere o, meglio, per riprodurre gli strani suoni e le cacofonie che le lingue non greche avevano per l’orecchio greco tutte le volte che lo incontravano. E si incontravano spesso Greci e non Greci, proprio sulle rotte del Mediterraneo, specie orientale, più facilmente percorribili degli accidentati territori peninsulari e insulari protesi nell’Egeo…
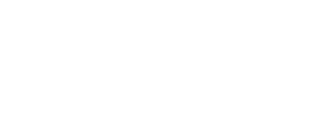
Mediterraneo polifonico: xenoi prima che barbaroi. Rappresentazioni greche del Mediterraneo antico.
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER